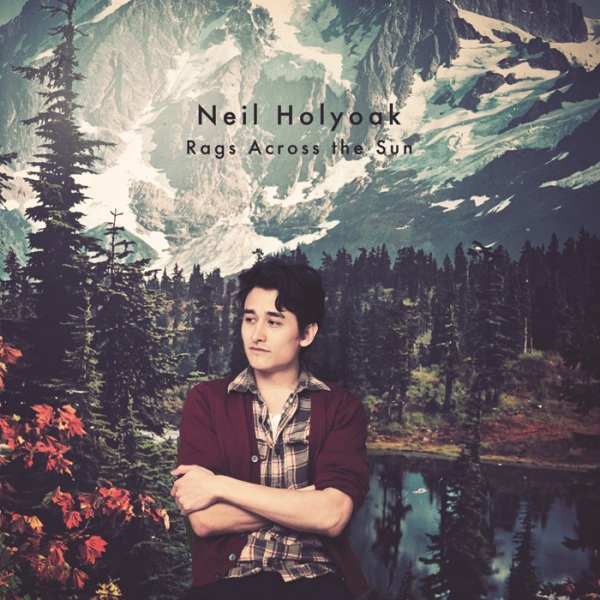Ogni volta che ci si prepara all’ascolto di qualcosa che sia stato forgiato dalla feconda e geniale mente di Claudio Milano, il sole della galassia InSonar/Nichelodeon, si ha sempre un po’ di riverente riguardo che non spinge istintivamente a pigiare il tasto play per far decollare le sue note. Sai che quello che ti aspetta sarà un lungo viaggio, intenso e profondo che ti travolgerà, volente o nolente, in un’esperienza che solo alla fine capirai in che misura incantevole, sulla base di quanto ti sentirai una persona migliore o meno. Serve del tempo per ascoltare, guardare, leggere, provare nel profondo del cuore tutto quello che è racchiuso in questo UKIYOE (il significato letterale è proprio mondi fluttuanti e si riferisce ad una cultura e conseguentemente un tipo di stampa nipponica) e proprio la necessità di tempo da dedicare all’arte è la peculiarità primaria che rende le opere targate InSonar/Nichelodeon quanto di più distante dall’universo musicale/commerciale attuale, dove le band durano il tempo di passare dalla neve al sole e i brani si metabolizzano come jingle pubblicitari. Questa disuguaglianza è la grande forza degli Insonar/Nichelodeon ed anche il colossale limite che forgia il destino di Milano dentro la gabbia senza sbarre della nicchia underground.
L’ultimo mio approccio con i Nichelodeon risale allo scorso anno, in occasione dell’ascolto di L’Enfant et le Ménure/Bath Salts che fu per me anche l’occasione di conoscere l’altra creatura nata dalla mente di Milano, gli InSonar, ormai diventati una sorta di gemello siamese del più noto progetto Avant Prog. Si trattava di un lavoro enorme, sia come durata (quattro i dischi che lo compongono) sia per energia; un album che mi trascinò per mesi e che, ancora oggi, mi divora lo spirito in quei giorni in cui la consuetudine non basta. Quel disco, che fu l’apice di tutti i miei ascolti di quell’anno, è diventato indiscutibilmente la pietra di comparazione per ogni altra realizzazione di Claudio Milano, che si parli delle fatiche precedenti o di quelle future, il punto massimo che probabilmente mai si potrà valicare. Proprio in quest’ottica, vado dunque ad approcciarmi al nuovo UKIYOE, cercando di tralasciare, per quanto possibile, gli aspetti formali e biografici che ormai dovrebbero essere noti a tutti o che altrimenti v’invito a ricercare negli antecedenti scritti inerenti al nostro Milano. L’opera (in uscita a novembre per Snowdonia), come spesso accade, non si limita a una proposta uditiva e, come per il precedente prodotto, si mostra come una raccolta di stelle, ospiti più o meno noti ma comunque tutti d’importanza capitale in ambito sperimentale e vocale. Troveremo dunque la complicità di OTEME, Deadburger Factory, Garden Wall/Genoma, dei compositori Josed Chirudli ed Erica Scherl, di alcune tra le più grandi voci italiane del momento come Dalila Kayros, Stefano Luigi Mangia, Laura Catrani e tanti altri. Il punto di partenza dal quale tutto muove, il concept attorno al cui orbitano parole, musica, disegni e immagini, è il mare con i suoi movimenti, la costruzione e la distruzione della forma qui trasformata in sostanza materiale attraverso il lavoro di Milano che ha condotto i diversi arrangiamenti dei tanti compositori, assegnando in studio a ognuno un canale, alzato e abbassato in maniera improvvisata per comporre una struttura sia consistente, sia luminosa, alternativamente.
Prima di passare alla musica, merita attenzione l’artwork del digipack, realizzato con le illustrazioni dello stesso Milano. Disegni splendidi, gonfi di colori freddi che si mischiano a immagini confuse creando una specie di fusione tra un mondo reale, dato dalla solidità apparente della terraferma delle umane certezze, e uno formalmente illusorio dato dalla fluidità della coscienza, dal mare e da tutti quei movimenti dell’animo che esso inevitabilmente genera e che l’hanno reso il protagonista di una vastità di opere letterarie divenute capisaldi anche della nostra personale formazione culturale e umana, da Proust a Melville, da Conrad a Hemingway. Dopo aver goduto delle illustrazioni che ho potuto apprezzare anche nel formato originale, si passa all’altro elemento non prettamente musicale dell’opera. Il Dvd che affianca il disco è un breve film del regista d’avanguardia Francesco Paolo Paladino, promotore del progetto e finanziatore dello stesso. Quickworks & Deadworks, questo il titolo, affronta lo stesso tema partendo dalle inquietudini che l’atmosfera marina suscita, ovviamente con l’aiuto della musica degli InSonar/Nichelodeon. Le fotografie del film, della durata di circa mezz’ora, saranno le stesse che, mescolate alle illustrazioni, comporranno l’artwork. Una piccola nave spiaggiata ai piedi d’un bosco, una voce fuori campo che descrive il momento, due coppie, una di giovani vestiti di bianco, una di adulti in nero, si allontanano dall’imbarcazione, avvicinando l’obiettivo. Si ritrovano su una terrazza. La telecamera è fissa e riprende il quadrato nel quale i quattro sembrano idealmente imprigionati. I giovani chiacchierano allegri sul parapetto, gli adulti, preoccupati e quasi disperati, sono seduti alle sedie d’un tavolino. I loro mondi paiono distanti ma con il passare del tempo, il salire del vento, quei mondi finiranno per collimare.
A questo punto approdiamo alla parte musicale, ai sei brani che compongono i mondi fluttuanti qui dipinti. Come i più attenti seguaci del verbo Nichelodeon potranno immaginare, oltre alle sette ottave donate dalla voce di Milano, il tutto si compone di una marea infinita di strumenti e musicisti. Violino, violoncello, arpa, viola, clarinetto, sax, voci di ogni tipo, chitarre di ogni tipo, elettronica, le più disparate percussioni anche non convenzionali e tantissimo altro. Scegliere dei punti di riferimento precisi è difficile. Si citano da Robert Wyatt all’accoppiata Nico / Cale, dagli Swans recenti di The Seer a Henry Cow, da Fausto Romitelli a Scott Walker, passando per David Sylvian, Kate Bush, Radiohead, Liars, Ulver, Carla Bozulich, Tim Buckley, Burial, Nine Inch Nails, Tool, Joy Division, Dead Can Dance, Current 93 e tantissimi altri. Talmente numerosi che pare di aver detto tutto che è un po’ come non dire niente. Perché alla fine non mente Milano quanto indica tutti questi come punti di riferimento; in fondo, ogni album che un musicista ascolta nel profondo fino a farlo veramente suo, finisce per costruire anche un solo piccolo frammento della personalità di quell’artista e, inevitabilmente, ogni pezzettino di sé andrà a costruire in un modo o nell’altro, ciò che poi è il risultato del suo estro. Tuttavia non lasciatevi ingannare da questi nomi. Le sperimentazioni di Claudio Milano solcano gli stessi mari già attraversati in precedenza. Dunque sarà la Modern Classical a farla da padrone, sullo sfondo di una voce sempre tesa tra melodia e sperimentazione (“Veleno”) o ancora le reminiscenze da scena di Canterbury (“Fi(j)uru d’acqua (Fiore/Figlio d’acqua)”), le tensioni nervose dell’Avant Prog (“Marinaio”), la teatralità di certo cantautorato (“Ohi ma(Nel Mare che hai dentro)”) che non disdegna di usare il dialetto per rendere al meglio certe suggestioni. “I Pesci dei tuoi Fiumi (Ezechiele 29:4; 29:5)” è forse il momento più terrificante, spaventoso e violento, certamente a suo mondo più moderno, quello che più si strappa dal passato per protendersi verso le future trepidazioni di un certo Art Pop sperimentale, enigmatico e apocalittico, quasi musica astratta se non fosse per le parole (in questo disco sempre o quasi in lingua italiana) che imprimono precise linee di demarcazione che altrimenti sarebbe impossibile seguire. Avanguardia pura che trova il suo compimento nella conclusiva “MA(r)LE”, che regalerà anche magnetismi autechriani ma dal sapore mediterraneo oltre ad un’infinità di altre immagini che spazieranno attraverso tutte le influenze suddette dei nostri, in una sorta di lungo excursus riassuntivo.
Giunto alla fine, resta l’impagabile soddisfazione di non trovarsi mai tradito da un artista che indubbiamente amo ed ho il piacere di seguire in ogni sua nuova esperienza. C’è da tornare però a valutare l’opera usando come pietra di paragone quel già citato L’Enfant et le Ménure / Bath Salts e, non posso negarlo, questo UKIYOE (Mondi Fluttuanti) non regge minimamente il confronto. Il fatto stesso che si tratti di una sorta di concept finisce per ingabbiare l’opera laddove al contrario, il quadruplo album precedente aveva il grande merito di spaziare e svariare così tanto da somigliare a quello che in letteratura potrebbe essere un capolavoro come Infinite Jest di David Foster Wallace. Qualcosa di tanto complesso eppure coinvolgente che a ogni ascolto/lettura ti pare di scoprire una parte di te, una sorta d’immaginifica bibbia emotiva personale che non rappresenta solo un momento della nostra esistenza, ma la racchiude in tutta la sua complessità. In questo nuovo album invece, tutto quell’universo è ricondotto e fuso in un unico elemento che, per quanto denso, risulta di più complessa compenetrazione. A livello prettamente formale, resta sempre eccelso il lavoro di Milano e dei suoi musicisti, sia come esecutore e cantante puro e sia come regista, coordinatore e demiurgo capace di far confluire idee e concezioni ineluttabilmente diverse in un archetipo comune e ben definito, che sappia prendere le lezioni di un passato che ha visto protagonisti nomi quali i già citati Buckley, Wyatt o Cale e, allo stesso modo, legarle con le nuove idee di mostri come Swans, Burial, Walker. Le frasi dello stesso Milano spiegano meglio di chiunque altro come si sia giunti a tanto: “sono autore delle linee melodiche e ho strutturato gli arrangiamenti, a cui pure ho preso parte, chiedendo a diversi musicisti di realizzarne una propria “visione musicale”. Nessuno è stato messo al corrente di quello che stavano producendo gli altri. Impiegando infine lo studio di registrazione come “un musicista a sé”, ho poi editato e montato creativamente i diversi arrangiamenti, come mossi dai flussi delle onde. In breve, tanta gente a bordo, due soli capitani, io e il sound designer Paolo Siconolfi. Le prime cinque copie del digipack saranno accompagnate da plaquette dell’artista Gloria Chiappani Rodichevski. Ognuna delle plaquette recherà tramite illustrazione (io ho un sistema di notazione assai pittorico su pentagramma) frequenza, altezza, durata e intensità della singola nota/sillaba che va a comporre il brano U-KI-YO-E che chiude idealmente il CD. Le plaquette saranno dunque tutte differenti e se lette una accanto all’altro attraverso l’incontro ideale dei singoli possessori, permetteranno di cantare o suonare il “tassello mancante” di un lavoro, di fatto, strutturato alla stessa maniera di un mosaico”.
UKIYOE (Mondi Fluttuanti) è un’opera immancabile e imprescindibile per ogni amante di sperimentazione vocale e non ed è in questo che sta forse l’unico grande difetto di Claudio Milano. Qualche giorno fa, stavo chiacchierando con Miro Sassolini, membro degli S.m.s. e voce storica dei Diaframma di Siberia, proprio di sperimentazione e circa l’importanza della voce dentro la musica. Quasi in maniera scontata si è finiti a parlare di Demetrio Stratos, il più grande utilizzatore di corde vocali che l’Italia ricordi, ed io non ho potuto esimermi dal tirare fuori proprio il nome di Milano. Sassolini ha confidato: “Claudio, che io stimo immensamente, ha studiato e ripercorso l’intera fase sperimentale di Stratos; forse non ce ne era bisogno. Forse bastava coglierne l’essenza ma questo è solo il mio punto di vista. Io e lui abbiamo cominciato più o meno dagli stessi territori di sperimentazione. Mentre io, però, ho seguito la strada della forma canzone, cercando sempre la melodia dentro la musica, lui ha braccato la purezza, legandosi piuttosto ai suoni, alla ricerca della complessità e alla metodologia estrema. Semplicemente abbiamo avuto diverse progettualità dettate da difformi esigenze personali”. Una verità tanto schietta quanto un po’ malinconica perché proprio questo disco è destinato a essere amato da pochi, come tutte le cose che osano troppo e la consapevolezza che, in tal senso, ci sia stato quasi un passo indietro rispetto al passato, mi getta in una triste realtà in cui pare non esserci spazio per chi ha veramente qualcosa da dire, sa esattamente come farlo eppure parla una lingua sconosciuta a un popolo troppo pigro per imparare.
*un ringraziamento speciale a Miro Sassolini per la piacevole e intensa chiacchierata sul lavoro proprio di Claudio Milano e per i suoi preziosi consigli