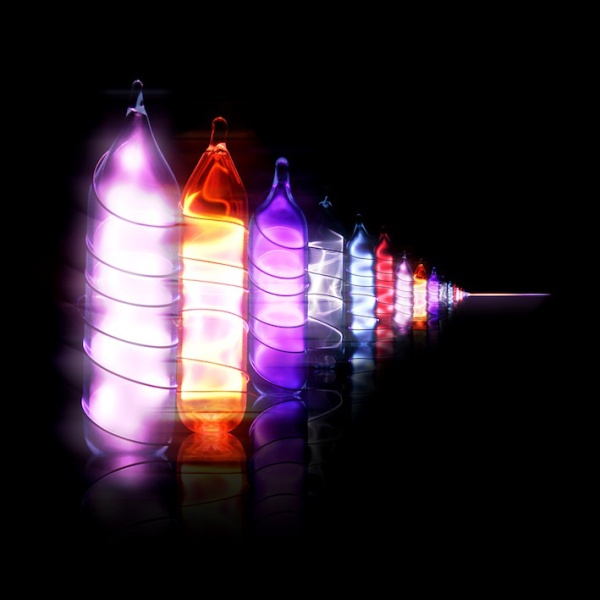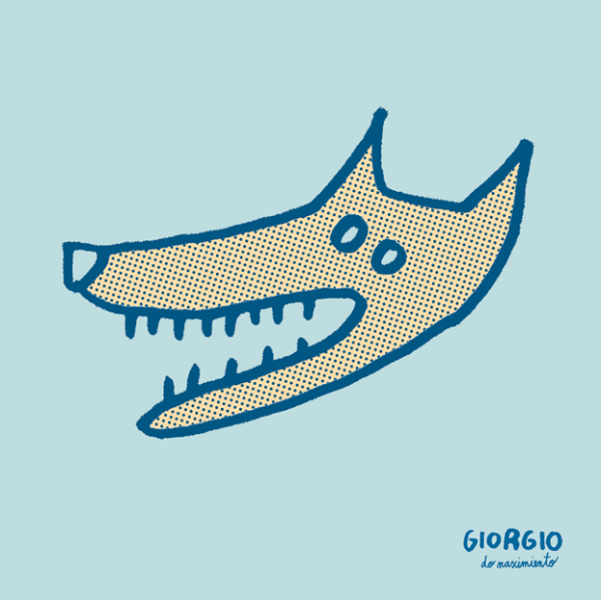From Scotland with Love è il titolo dell’album nato nel 2013 dai racconti di King Creosote, storie di una Scozia vissuta fino in fondo, scrutando i meandri più profondi della cultura e della vita del suo popolo, ma anche della musica popolare di cui si degna e che dona le sue classiche tradizioni musicali a questo disco (colonna sonora di un film-documentario di Virginia Heat) che appare molto delicato e morbido per le sue sonorità e le sue melodie atte a restare memorabili, ma che riesce ad alternare brani in chiave Folk a valzer romantici (come in “One Floor Down”) e a break ritmici più movimentati come in “Largs – Long” o anche “For One Night Only”. Anderson cerca infatti di rallegrare lievemente l’animo dell’ascoltatore, ponendo in un contesto malinconico un andazzo ritmico folkeggiante che abolisce il malumore, trascinandoti a ballare; oppure addolcisce vicende amare, come in “Bluebell, Cockleshell, 123”, dove alla cruda presenza della morte accosta un delizioso coro di voci bianche. “Cargill” è l’unico duetto dell’album, ed a raccontare il brano sono gli occhi di una donna che prega nostalgica per il suo marinaio, un po’ come fu per “Suzanne” di Leonard Cohen ai suoi tempi.
In questo scenario tetro in cui la Scozia viene messa a nudo, uno dei temi fondamentali è la speranza racchiusa in un credo come “Something to Believe in” o una utopia energica che mira all’essere ripagati di un grosso sforzo, ovvero quella di “Leaf Piece”. La decima tappa di questo viaggio è la chiave principale dell’album, in quanto “Pauper’s Dough” è paragonabile a quella mano che ti viene tesa dopo averti spinto a terra, anche se il testo (di natura politico-sociale) tenta di separarmi da quest’idea. Infine “A Priaire Tale” riprende la strumentale introduttiva di “Something to Believe in”, riarrangiata con archi che sostituiscono le tastiere, essa potrebbe essere definita la “firma” alla fine della missiva, il brano di chiusura, infatti, è come un saluto che l’autore avanza con linguaggio musicale, dicendo: “From Scotland with Love”.