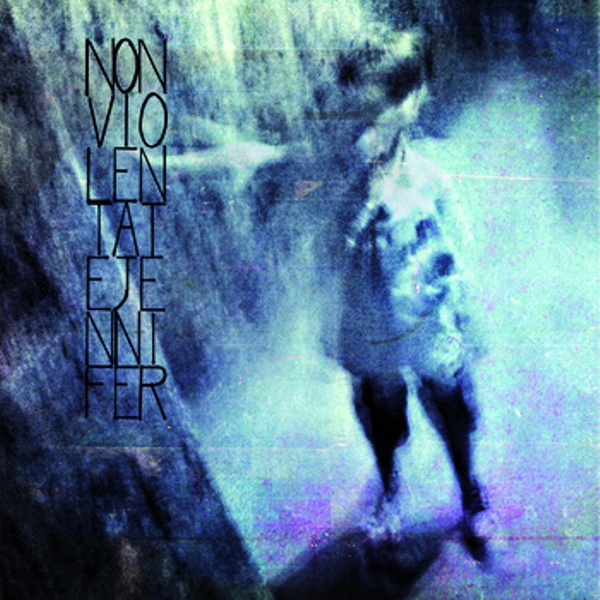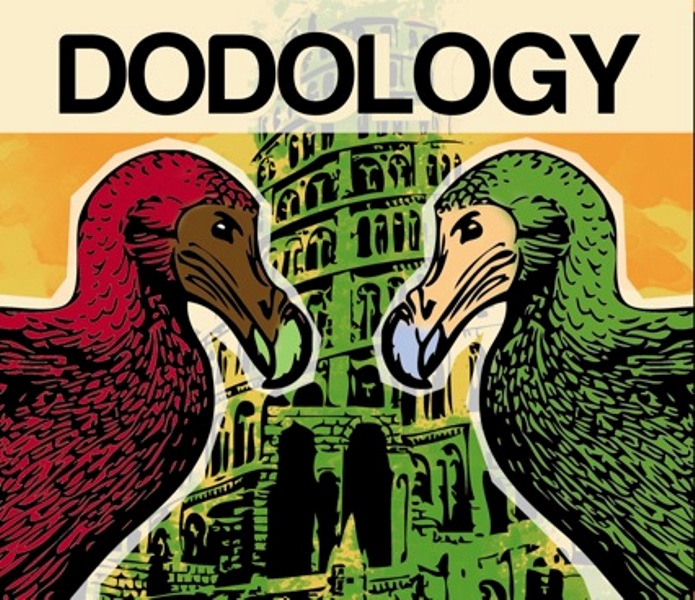Non so se vi è capitato di dare una scorsa a quell’articolo di tale Mr. Tambourine (Claudio Delicato, credo sia il suo vero nome) pubblicato sul blog ciclofrenia.it. L’intento era quello di punzecchiare l’indie italiano sviluppando e cercando di dimostrare la tesi che, per costruire un disco di sicuro successo, è sufficiente seguire alcune semplicissime consuetudini. Tralasciare completamente l’aspetto musicale, parlare solo di cose inutili, essere completamente incapaci a suonare, non cantare ma parlare, scrivere canzoni tutte uguali e ideare un particolare curioso completamente a caso. Lasciamo stare il fatto che il testo finisce per essere grossolano e inconsistente, almeno ai miei occhi, tanto quanto tanta della musica che proprio l’articolo aggredisce (mettere nel pentolone i Massimo Volume è oltretutto intollerabile). In realtà, qualche pretesto stimolante lo fornisce. Soprattutto offre a me lo spunto per ciarlare dell’Ep dei Non Violentate Jennifer, trio composto da Zà (voce, piano, organo), Max (basso) e Al Bin (batteria). Partiamo da un punto che manca nell’articolo. Inserite nel nome della vostra band quello di una donna. Piacerà, anche se qualcuno, come il sottoscritto, comincerà una bestemmia lunga fino al 2025 perché non se ne può più di sentire nomi del genere. Marta Sui Tubi, Christine Plays Viola, Non Voglio Che Clara, Valentina Dorme, ecc… (la lista è veramente lunga). Mai che si legga un Bruno Caga Nei Prati, Fausto Scoreggia In Chiesa, Ubaldo Fa Sesso Anale Passivo. Non Violentate Jennifer è, come posso dire, già un modo per partire con il piede sbagliato. Ora, può anche essere vero che il loro sia solo un omaggio al revenge movie I Spit on Your Grave, diretto da Meir Zarchi nel 1978, ma che ne sanno i poveri mortali di queste cose? Lasciamo andare il nome e passiamo alla musica. Quanto questa musica può portare al successo?
Una band che si offre con un Ep cosi disadorno, con poche notizie che circolano intorno, che sembra una bestia difficile da scovare, forse vuole proprio puntare tanto sull’aspetto musicale a dispetto del problema iniziale di cui sopra (più sopra, verso l’inizio). E il punto uno va a farsi fottere. I testi non sono certo banali e semplici e di sicuro non parlano di cose inutili; non puntano su ironia o leggerezza e anzi hanno bisogno di una certa dose di attenzione per essere elaborati oltre il semplice legame musicale con le note. Anche il punto due va a puttane. Sulle loro capacità di suonare è difficile esprimersi. Non sembrano fenomeni ma nemmeno incapaci. Il punto è che la musica si sviluppa per linee estremamente semplici (come ascolterete, questa è la sua forza) e dunque è arduo capire quanto siano validi. Quello che conta è che fanno bene quello che devono fare. Cazzo, se ne va anche il punto tre. Non cantare, ma parlare. Qui, forse ci siamo, perché il modo di cantare di Zà molto capovillano è uno strumento che si piazza in una terra di mezzo che ha anche più probabilità di successo dello spoken word tipico ad esempio di Emidio Clementi (Massimo Volume) o Max Collini (Offlaga Disco Pax) che nel loro modo di vocalizzare hanno trovato il principale ostacolo all’apertura verso un pubblico più copioso. Il successo per Non Violentate Jennifer si avvicina? Basta questo? Purtroppo le canzoni, per quanto mantengano una linea guida abbastanza precisa, non suonano tutte uguali e qui non ci siamo proprio. Infine, per il particolare completamente a caso, non mi sembra di trovare nulla. Forse….anzi…no. Niente.
Volete un bilancio, prendendo per buone le regole sopra indicate? Questa band è molto lontana dal successo. Non hanno niente a che vedere con i compatrioti I Cani, Lo Stato Sociale, Dente, Brunori e compagnia delle indie.
I quattro pezzi sono invece un’interessantissima miscela di sonorità psichedeliche sixties, pesantezza tipica stile di Nick Cave/Nick Drake, energia alla Jesus Lizard nelle loro virate meno estreme, slowcore folk blues come i Black Heart Procession (la band alla quale più somigliano), intermezzi pseudo sintetici, affascinanti note di piano e ritmiche ossessive caratteristiche di un certo post punk vecchia scuola. “Terza Persona”, “Nel Paese Degli Umani”, “Tutto Finisce All’Alba” e “Naufragheremo” sono il perfetto punto di partenza per una band che voglia fare un grande disco, oltre il successo. Quei gioielli che conoscono in pochi e ti fanno sentire figo perché delimitano la differenza tra te e il resto della gente che hai intorno. Forse troppe sono le influenze e poche le idee innovative ma per tutti i quasi diciassette minuti dell’Ep si respira una cupa aria trascinante che ti mette voglia di ascoltare e stare male, ma di quel male di cui abbiamo bisogno per stare bene. È una nebbia misteriosa, Non Violentate Jennifer. “È un grido rivolto al mondo, è una preghiera, è la richiesta che il mondo si fermi ma già consapevole che questo non accadrà, è una minaccia, un ultimatum alla natura distruttiva dell’uomo, è una condanna ai pochi uomini che si contendono il potere piegando le masse ad una colpevole forma di schiavitù involontariamente volontaria. Non Violentare Jennifer è un urlo disperato che non può fare niente da solo. È un canto di guerra che insieme agli altri può fare tutto”.
Non avranno successo, sono sicuro, perché il pubblico che ti porta al trionfo è un pubblico di merda. Tante delle puttanate dette sopra (più sopra, quasi all’inizio), se ci pensate, sono vere. Fare buona musica non porta alla fama. Ma credo che la cosa non interessi i Non Violentate Jennifer più di tanto. Del resto, ascoltate l’Ep e ditemi se ci vedreste bene un tipico ascoltatore de I Cani, a un concerto dei NVJ?