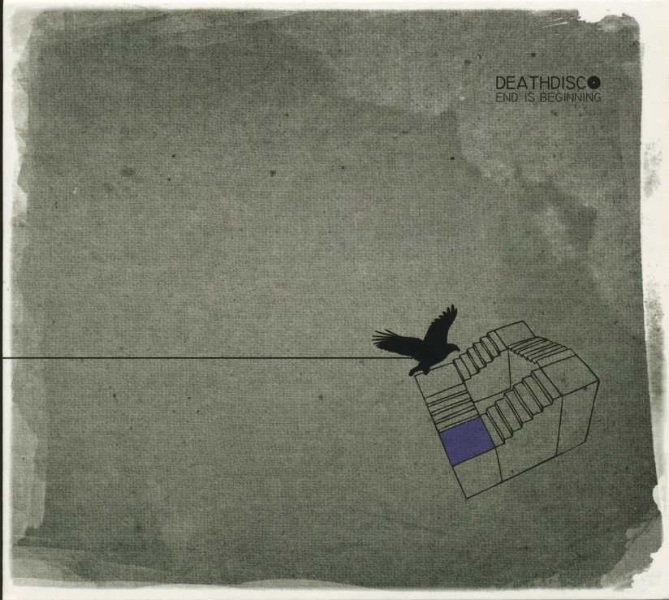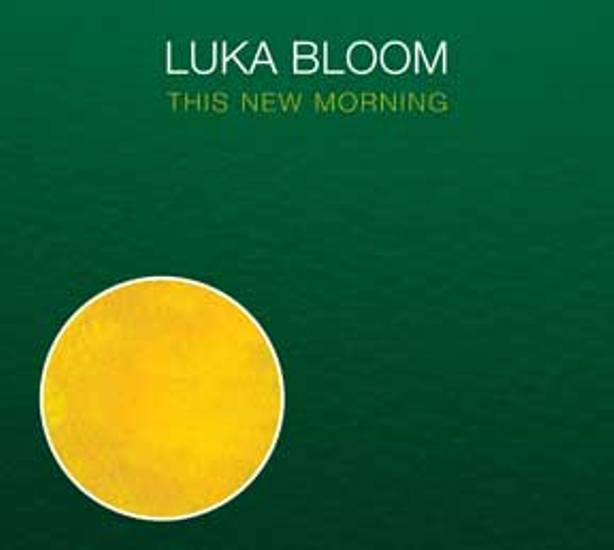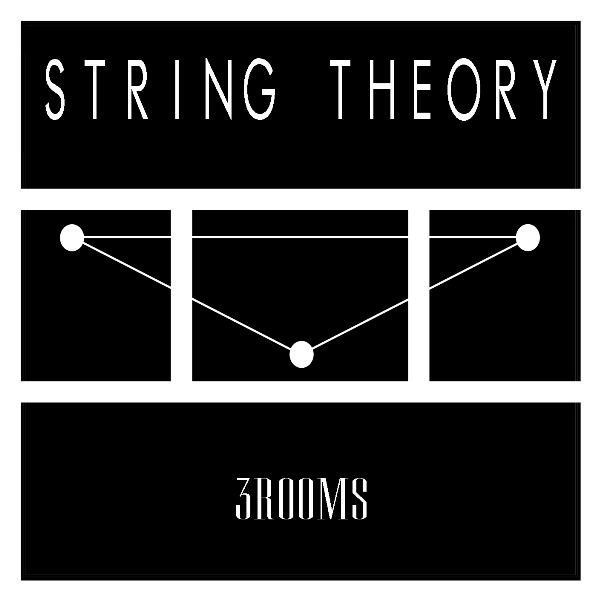Inizia un minuto prima, note folk tenui e delicate preparano l’ascolto del mio respiro. Bugie.
La band modenese Stop? capeggiata dalla voce di Daniele Paganelli e arricchita da Eronne Bernucci alla chitarra, Enrico Maria Bertani alla batteria e Michele Zanni al basso e rhodes, prova a fare le cose in grande ma finisce per perdersi tra le sterili note pompose e dozzinali al tempo stesso e le parole belle e poetiche che fanno da cuore dell’intera opera, tanto affascinanti quanto poco esaltate dalla musica. Momenti Hard Rock estremamente educati e inefficaci, intervallati con pezzi Pop Rock sconcertanti, finiscono per frantumare quella che poteva essere, sulla carta, una gemma di valore assoluto.
Il motivo è banale. Quando si parte da un presupposto che sembra consigliarti di dover necessariamente apprezzare, la delusione è la conclusione più ovvia. Un artwork ammaliante incastona i testi che si uniscono a creare un’unica lettera, come versi d’una poesia che si chiude con le parole Aiutami tu.
Dopo l’ukulele che folleggia nell’intro strumentale “Un Minuto Prima”, creando un contrasto a mio avviso sovrabbondante, inizia la parte vera del lavoro degli Stop?, col brano “7:55”. Passaggio sparato a mille che, anche per la vocalità di Daniele Paganelli, ricorda sia la miscellanea dei Quintorigo di John De Leo, sia l’energia degli Jane’s Addiction di Perry Farrell, senza dimenticare anche alcuni strappi molto Faith No More, specie nei cambi di tonalità. Con “Come Dimenticare Le Mie Paura” si abbassano i toni e l’atmosfera si fa più intima. Poche parole echeggiano sopra una melodia non troppo azzeccata, finendo per suonare come un brutto pezzo Pop/Rock di un B-Side di Francesco Renga.
Ho ascoltato solo un intro e due pezzi e già non si capisce un cazzo di quello che vogliano suonare gli Stop?. L’unica cosa che sembra chiara è che, se da un lato dimostrano di avere puntato molto su testi e arrangiamenti, dall’altro sono veramente poco bravi nella creazione di melodie che siano orecchiabili o, per contro, sorprendenti.
Con “Splenderai (Aria Vergine)” si mantiene la stessa linea carnale del brano precedente ma le chitarre riprendono quel retrogusto folk presentato nell’intro che altrimenti non avrebbe avuto veramente alcun senso. Il ritmo è semplice e cadenzato e il tutto sembra un tentativo malriuscito di mettere in risalto le parole che, per quanto interessanti se lette come fossero poesia su carta, risultano fumose nel complesso dell’opera.
Con “Lasciamo Il Tuo Odore” e il suo attacco in crescendo le cose paiono migliorare ma bastano pochi secondi per capire una cosa che forse avevo solo avvertito in precedenza. Questa è roba che di certo piacerà a tanti, non ho dubbi. È proprio la musica che tanta gente va cercando. Ma non io. Mi ritorna continuamente in mente Renga che canta un pezzo del cazzo a Sanremo e se da un lato la colpa è della piattezza della musica, il vero colpevole è (non me lo aspettavo) la voce di Daniele Paganelli. Una bella voce, che si esalta nei cambi di tono e che sembra perfetta per il Pop da prima serata di Rai Uno. Ma sono troppo vecchio e ancora troppo giovane per queste cose. Vorreste mai che vostra figlia uscisse con uno di loro? Erano queste le espressioni con le quali presentarono I Rolling Stones nel 1963. Questo era e dovrebbe essere la musica, almeno per come piace a me. Per gli Stop? La mia risposta sarebbe un tranquillo “Sì, ce la porto io”. A me, però, non interesserebbe mai un tipo che io farei uscire con mia figlia.
Basta divagazioni, torniamo alle canzoni.
“Divertiti” è forse il primo brano che mette voglia di riascoltarlo. Un’ ipnotizzante cantilena, con una voce monotona e cupa in stile Giovanni Lindo Ferretti, chitarra ebbra e sezione ritmica ossessiva. Voci che si sovrappongono e crescendo che sfocia in un vortice sonoro lisergico assolutamente incantevole.
Niente da fare. Con “Ti Sopporto Più” (mai parole furono più indovinate) tutto torna a tediarmi l’anima. C’è un po’ di energia in più e alcune distorsioni chitarristiche fanno venire un minimo di acquolina alle orecchie ma ormai è chiaro che non c’è niente che possa defibrillare questa piatta morte. C’è di buono che il pezzo risponde, almeno in parte, alla mia postuma domanda: “Che cazzo c’entra “7:55” con tutto il resto?”.
Mi rendo conto con “Insensibile” che la seconda parte è indubbiamente più Rock (per modo di dire) ma siamo sempre in quell’universo del Rock, dove i campioni sono Le Vibrazioni, per cui non mi sembra troppo il caso di insistere. Il penultimo brano, puntando su atmosfere cupe e angosciose stile Piano Magic, da il titolo a tutto il disco e ne rafforza la robustezza spirituale pur non aggiungendo molto allo stile, mentre è l’ultimo brano, “Lettera Bianca” a dare un senso a tutto questo. Non c’è musica, semplice Spoken word. Teatro e parole che, per la prima volta, oltre ad essere intriganti e musicali come pura poesia, sono anche incisive e coinvolgenti. Se solo ci fosse stato un minimo di musica, come vento a riempire gli spazi vuoti tra le lettere…
Vi giuro che non lo dico tanto per stroncare senza stroncare. Gli Stop? hanno tutte le carte in regola per sfondare in mondo popular che non mi riguarda e per presentarsi a Sanremo e vincere, magari, nella sezione emergenti e poi andare in radio e far gridare al miracolo Mollica dopo il Tg1. Possono farcela. Ma siccome io non sono la Maionchi e del successo di un gruppo non mi frega un cazzo, per me è no!