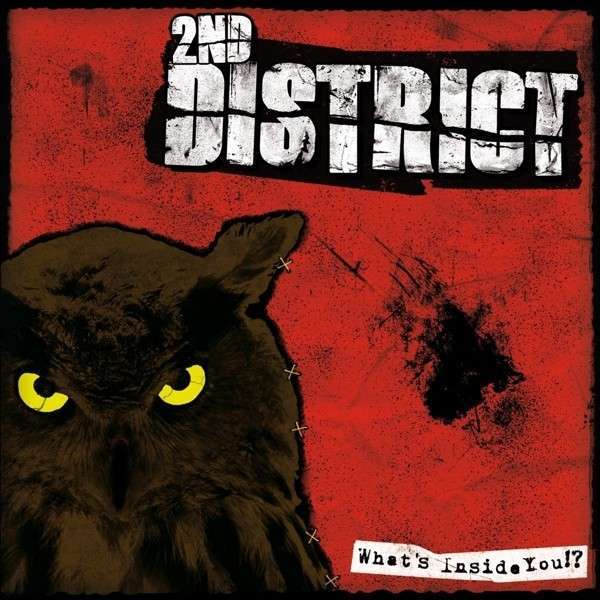Silvio “Don” Pizzica
InSonar/Nichelodeon – L’Enfant et le Ménure / Bath Salts
Due creature distinte, una neonata, InSonar, l’altra vecchia conoscenza dell’Avant Prog, Nichelodeon, ruotano entrambe attorno alla figura di Claudio Milano. Uno split composto di quattro cd per due parti. I primi due firmati InSonar sono avvolti in un booklet contenente alcune opere di Marcello Bellina (in arte Berlikete) e quindi mosaici di Arend Wanderlust. Il progetto di Claudio Milano e Marco Tuppo vede la partecipazione di sessantadue musicisti da tutti i continenti. Il terzo e quarto cd, a firma Nichelodeon, vedono un booklet che contiene i dipinti e le poesie visive di Effe Luciani e le foto di Andrea Corbellini. La musica che è contenuta è un tripudio di Rock Sperimentale, Jazz, Progressive, Pop, Cantautorato, Ambient, Psychedelia e tanto altro. Difficile spiegarlo in poche parole.
Deadburger Factory – La Fisica delle Nuvole
Il collettivo work in progress, definito in questa circostanza “factory”, confeziona tre dischi sensazionali, ognuno vivo di una propria essenza, eppure capace di collimare nell’altro con efficacia. Musica sperimentale per gente normale.
Twomonkeys – Psychobabe
I due fratelli bresciani affermano il loro ruolo nel panorama elettronico italiano, rivelandosi come l’alternativa tricolore agli Animal Collective. Il loro è un album che deve tanto alla psichedelia di Panda Bear e soci ma disdegna incursioni nel mondo Indie e Garage Revival e nella sperimentazione matmosiana.
Marco Lavagno
Albedo – Lezioni di Anatomia
Un disco geniale. Ogni brano è un organo del nostro corpo. Indie rock che suona fresco, dinamico, melodico, forte come una voce che risuona nella nostra cassa toracica. Un lento viaggio emotivo dalla testa ai piedi.
Nadar Solo – Diversamente Come?
Potenza e testi generazionali. Il suono della band torinese è senza fronzoli, incredibilmente moderno. Canzoni per sognatori che si schiantano a terra ma non perdono mai il coraggio di sognare ancora. Nulla di più necessario al giorno d’oggi.
Perturbazione – Musica X
E’ stato etichettato, ancora prima di uscire, come il disco “elettronico” di un gruppo che ha sempre integrato le corde (non solo quelle della chitarra) al suo tratto somatico. Max Casacci entra prepotentemente nel sound e lo “perturba” senza snaturare la sua semplicità. Un applauso al coraggio e alle grandi canzoni che questi ragazzi riescono ancora a scrivere dopo 25 anni.
Diana Marinelli
Carmilla e il Segreto dei Ciliegi – Anche Se Altrove
La musica come essenza di infiniti mondi mentali. Anche se Altrove è una porta, un varco che se attraversato porta ad un’esistenza parallela fondamentale per ricominciare un nuovo viaggio, sulle vie e sulle emozioni di una vita già vissuta, forse da cui prendere esempio. Un lavoro molto interessante, studiato e soprattutto vissuto nel tempo.
ILA & The Happy Trees – Believe it
Roba da donne. E se questo significa bel timbro, bella musicalità e bell’intonazione, sia in italiano che in inglese, allora sì, è roba da donne. Tante persone, tanti colori e tante esperienze che si incontrano per un album per certi versi solare, dove protagonisti siamo tutti noi con la voglia di fare tanto e di lavorare per cambiare ciò che ci sta stretto. Una musica che lascia addosso belle sensazioni e belle emozioni.
Bruno Bavota Ensemble – La Casa sulla Luna
Il fascino di una melodia malinconica e di un pianoforte senza tempo, che però il tempo ce l’ha eccome e non solo uno preciso di metronomo ma un tempo di un determinato momento storico musicale, quello minimale/contemporaneo. Un lavoro che impone tanti interrogativi ma che ho rivalutato nel corso del tempo grazie alle sensazioni che lascia addosso. Sensazioni sincere.
Simona Ventrella
Fast Animals and Slow Kids – Hybris
I ragazzacci perugini hanno confezionato un secondo album esplosivo nel quale non mancano talento, energia e passione a tutto gas. Probabilmente quest’album rappresenta per loro un vero salto di qualità, che li ha portati in giro per l’Italia con un lungo tour e li ha fatti conoscere e apprezzare ad un pubblico maggiore.
Appino – Il Testamento
Primo lavoro solista del frontman degli Zen Circus da dieci più, testi profondi e mai banali, cantautorali al punto giusto conditi da un sound deciso, cupo e decisamente Rock.
Green Like July – Build a Fire
Terzo album per il gruppo milanese che ci offre un lavoro ricco e variegato impreziosito dagli arrangiamenti di Enrico Gabrielli. Una tavolozza di colori e atmosfere che ti catapultano in altrettanti mondi sonori. Il cambiamento rappresenta per questo lavoro il leitmotiv che giuda le nove tracce verso un Pop fresco e moderno.
Riccardo Merolli
Soviet Soviet – Fate
Fate è ipnotico, avvolgente, straniante, di quei dischi in cui perfino le imprecisioni ti sembrano messe ad arte. I Soviet Soviet dimostrano appieno di aver digerito la lezione New Wave e Punk.
Cosmo – Disordine
Immaginate Lucio Battisti catapultato negli anni dieci sopra una DeLorean con tutte le diavolerie tecnologiche di questo periodo storico e l’intenzione di incidere Anima Latina, il risultato sarà un disco terribilmente Elettro Pop.
Albedo – Lezioni di Anatomia
Disco bomba. Arriva dritto dentro lo stomaco, Post Rock emozionale e testi bellissimi. Meritano veramente tanto gli Albedo.
Marco Vittoria
Appino – Il Testamento
Difficile staccarsi dal cordone ombelicale, soprattutto se “la mamma” in questione è un’entità chiamata Zen Circus formata da tre validi musicisti che insieme formano un vero e proprio treno sonoro… Tuttavia Appino esprime a pieno la sua creatività artistica in questo lavoro, suo esordio da solista, non rinnegando il passato ma gettando anche le basi per un nuovo futuro… Mi chiedo quindi… Come suoneranno i nuovi Zen Circus nel 2014?
Gazebo Penguins – Raudo
Il trio emiliano torna ad imporsi come una delle realtà sonore migliori italiane a soli due anni di distanza dal precedente lavoro, “Legna” con una potenza e una grinta senza eguali che si distinguono sin dalla prima traccia “Finito il caffè”, pubblicato anche come singolo in contemporanea all’album. Messaggio per le generazioni di oggi: lasciate perdere gli artisti che emergono dai talent in tv e ascoltatevi un prodotto genuino e vero dell’underground.
Lolaplay – La Città del Niente
Loro ironicamente dicono in una canzone del disco: “non comprate questo disco e non ascoltate i Lolaplay o ucciderete anche voi la buona musica!”. La buona musica è invece tutta qui, sempre in bilico fra il Noise dei Marlene Kuntz, la New Wave anni ottanta e il Rock dei Dandy Warhols… Interessante vero?
Lorenzo Cetrangolo
Ministri – Per un Passato Migliore
Il Rock popolare italiano come dovrebbe essere oggi. Spigoloso e orecchiabile, potente e sentimentale. Una produzione ruvida per un disco da consumare.
Selton – Saudade
Brasiliani trapiantati a Milano, i Selton creano un disco veramente pop, nel senso più alto del termine. Non c’è una nota fuori posto, tutto scorre liscio e comodo, ma senza banalizzare nulla. Una delle migliori band in circolazione.
In Zaire – White Sun Black Sun
L’underground italiano, quello che spacca tutto. Tribali, energici, psichedelici. Un disco strumentale che ti rivolta il cervello come un calzino.
Vincenzo Scillia
Sophia Baccini’s Aradia – Big Red Dragon
Un disco proposto da un artista dalle mille sfaccettature. Particolare su ogni fronte, una ventata di freschezza ed un cavallo di battaglia dell’ etichetta.
Corde Oblique – Per le Strade Ripetute
La musica di Riccardo Prencipe è ormai un manifesto del Sud, di Napoli, dei Campi Flegrei. Questo un lavoro ispirato e sviluppato con tanta passione. Tutto ciò non fa altro che assegnare punti ai Corde Oblique oramai una certezza.
Lili Refrain – Kawax
Kawax di Lili Refrain è un disco sperimentale, atmosferico. E’ un irrefrenabile viaggio mentale accompagnato da colori neri come l’ oscurità, rosso come la passione ed un sinistro verde scuro. Insomma una perla di questo 2013.
Giulia Mariani
Luminal – Amatoriale Italia
Distorti, veloci ed incazzati, con Amatoriale Italia i Luminal hanno fotografato e descritto al meglio lo scempio di quest’Italia marcia, corrotta, bigotta e intrappolata tra luoghi comuni inutili e finti alternativi contornati d’oro. Una botta di adrenalina pura!
Ekat Bork – Veramellious
Di origine russe ma stabilita nella svizzera italiana da una vita, Ekat Bork crea atmosfere elettroniche ispirate ad ambienti naturali come boschi e fiumi, condendo infine il tutto con una voce alla Florence Welch. Un album unico, che si contraddistingue per un’innegabile ricerca sonora, cura dei dettagli ed arrangiamenti complessi che rendono Veramellious un’esperienza d’ascolto dentro e verso un’altro mondo, un mondo fantastico ed etereo.
Miranda – Asylum: Brain Check After Dinner
Il trio fiorentino ritorna dopo quattro anni sfornando un concept album per reclusi e disadattati, tra grida di rivolta, suoni sintetizzati ripetitivi, attitudine punk, e chaos organizzato. Non so, sara’ perchè mi piacciono i piu’ internazionali Atari Teenage Riot, ma il fatto che Asylum: Brain Check After Dinner mi spacchi la testa ogni volta che lo ascolto mi fa impazzire!
Maria Petracca
Umberto Maria Giardini – Ognuno di Noi è un po’ Anticristo
Un viaggio psichedelico all’interno di sé stessi, sottoforma di EP. Severamente vietato a chi ha paura di guardarsi dentro fino in fondo, a chi non ha il coraggio di scoprire che non siamo né Santi né Eroi, come amiamo dipingerci. Perché c’è del bello e del brutto in ognuno di noi. In fondo, “Ognuno di Noi è un po’ Anticristo.
Dimartino – Non Vengo più Mamma
Anche in questo caso di EP si tratta. Chi aveva ancora dubbi sulle capacità cantautorati di Dimartino, con questo disco vedrà svanire ogni forma d’ incertezza. In più avrà modo di stupirsi di fronte ad un lavoro ricco di sperimentazioni: elettronica e cantautorato che vanno a braccetto per strada. A mio parere un esperimento riuscito. Fortunato chi ha potuto goderselo anche in versione live.
Perturbazione – Musica X
Ancora un sound più elettronico rispetto a quello dei dischi precedenti, ancora un esperimento riuscito per chi, da anni, propone una forma di Pop Rock d’autore capace di affrontare in modo leggero, ma mai banale, le varie tematiche legate alla vita quotidiana (e allo scazzo che irrimediabilmente ne deriva) e non solo. Nel 2014 avremo modo di ascoltarli anche a Sanremo.