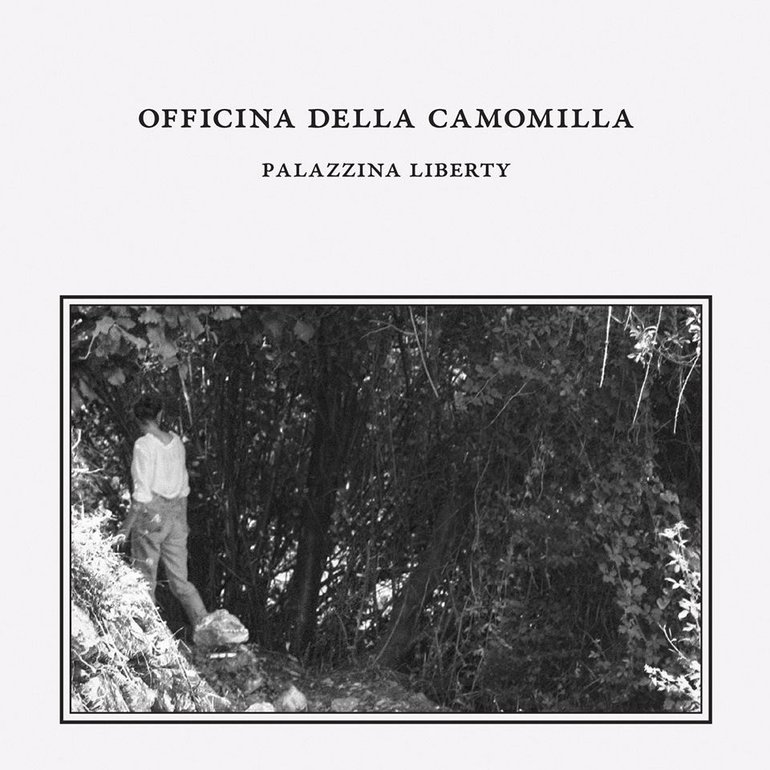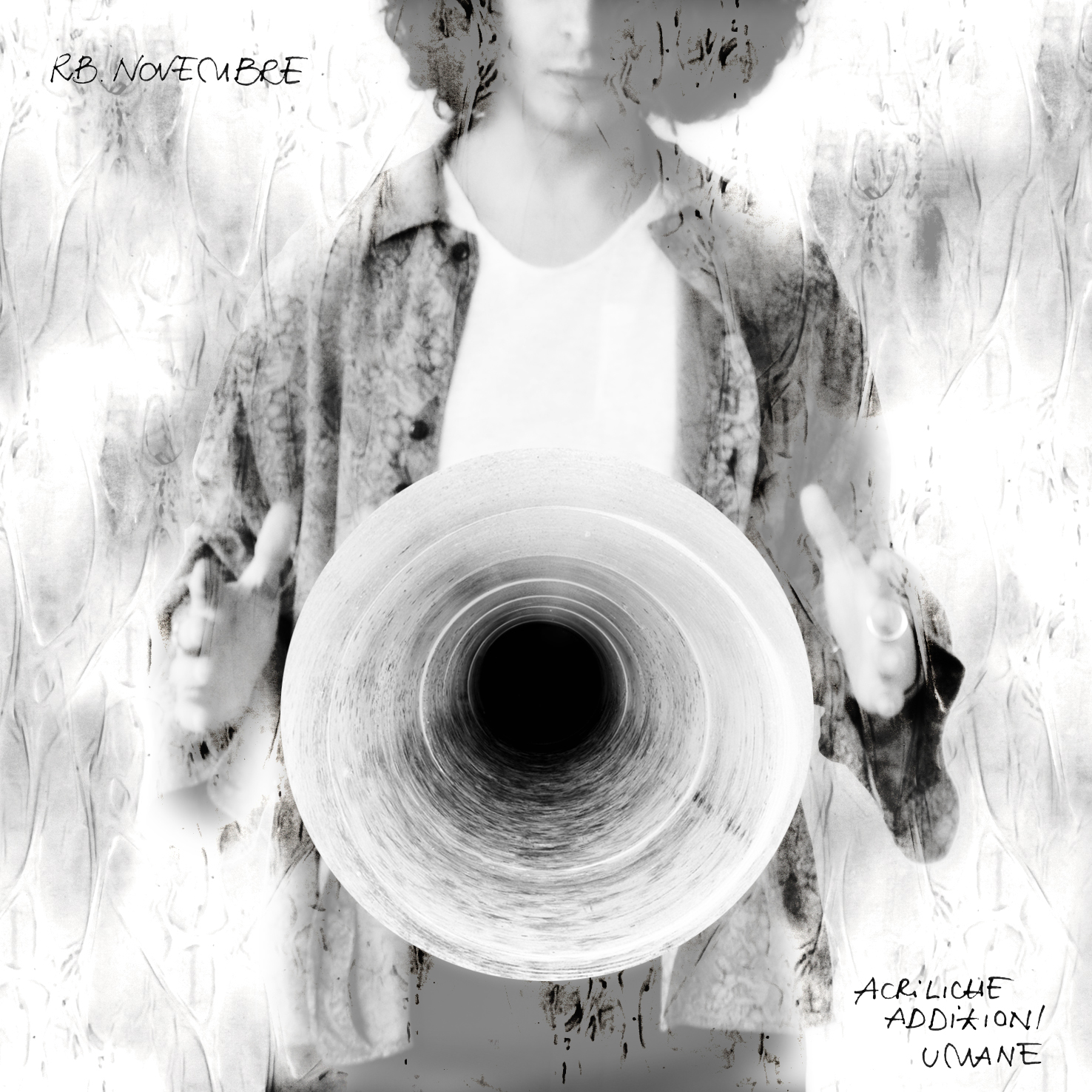Canzoni Della Cupa è il decimo album in studio di Vinicio Capossela. Diviso in due parti per 28 brani e una durata di più di due ore, Canzoni Della Cupa è un atto d’amore e di testimonianza verso un tempo passato che ormai è fuori dal tempo, mitizzato nell’immagine brusca e insieme rasserenante di una società contadina, ruvida e sincera, in cui si vive e si canta della vita, e quindi dell’amore, carnale soprattutto, ma sempre giocoso, vinoso, anche quando è serio; della morte e delle creature della notte, degli spaventi nelle ombre dei fuochi e dei monti sotto la luna; dei campi, dei poveri, del sudore, del lavoro; dei primi treni, dei viaggiatori, delle verità scolpite nella pietra dei proverbi e della saggezza popolare.
Ineccepibile nella produzione e nella resa, il disco continua la parabola del mito, della rivisitazione della tradizione (o tradizioni) che Capossela sta portando avanti da Marinai, Profeti e Balene (con in mezzo Rebetiko Gymnastas) ma che è stata da sempre una sottotraccia di tutta la sua produzione, interessata fin dai primi dischi alla rielaborazione del popolare/tradizionale (ritmi sudamericani, armonie mediorientali, atmosfere mediterranee).
Questo disco è l’ideale proseguimento di quella parabola e insieme il suo compimento totalizzante e definitivo: il ritorno nella terra degli avi, l’archeologia sentimentale nei racconti e nelle leggende, nelle storie e nelle musiche che erano la colonna sonora di un affascinante tempo che fu, che qui vira seppia, come le foto, e diventa quasi un’età dell’oro, un mondo che, nei suoi dolori, suonava forse più diretto e vero, più libero, certo più povero e più stanco ma senza perdere la fame d’amore, di festa, di paura anche, quella un po’ superstiziosa che eccita e riunisce il gruppo intorno alle luci e ai canti dopo l’angoscia, il cuore affaticato e una spaventosa, fantastica storia da raccontare.
Non sorprende quindi scoprire che Canzoni Della Cupa fosse in cantiere da più di dieci anni: è una sempreverde voglia di mito a spingere Capossela verso la rielaborazione e la testimonianza per riportare al suo oggi delle tradizioni che, sotto la polvere e oltre l’ombra della memoria, appaiono estremamente vive, anche (e soprattutto) grazie alle sue doti di interprete e riscrittore eccelso, maestro del racconto, sciamano della voce e della parola.
La nota dolente, per i fan del cantautore, potrebbe però nascondersi qui attorno: scavando si trovano tesori, ma ci si ingobbisce; gli occhi si fanno miopi a guardare tanta terra smossa. Canzoni Della Cupa è un progetto ambizioso, pensato ed eseguito senza passi falsi o sbavature (non ci saremmo aspettati di meno); è un racconto mitico e preciso, immaginifico e appassionato, da godersi senza remore, scoprendo in ogni brano una storia affascinante, divertente, incredibilmente vicina. È perciò con una certa amara sorpresa che alla fine, quando rialzi gli occhi stanchi dalla terra e dai suoi tesori, ti accorgi di quanto sia ormai sfocato e nebbioso l’orizzonte: lontano più di quanto, forse, dovrebbe.