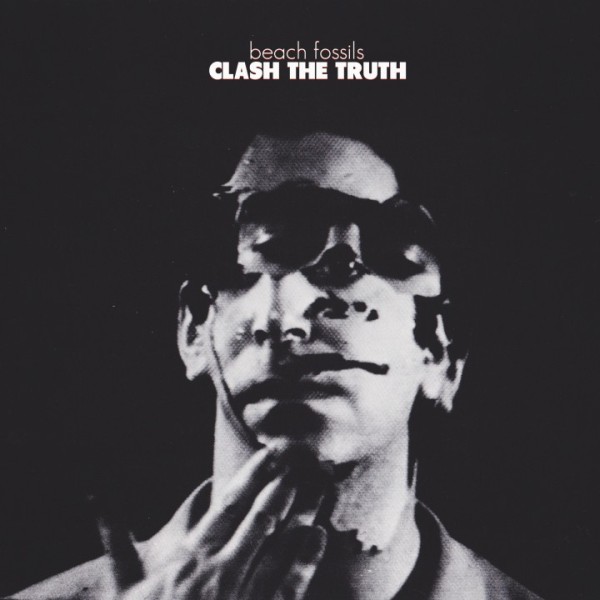Lento è il viaggio verso le stelle, lento è un movimento nello spazio. Questa è musica che richiede pazienza, calma ma forse parliamo addirittura di meditazione e di sogno. Richiede una serata tranquilla per far viaggiare i propri pensieri, spararli nel cielo stellato lontano e pacifico, senza aver paura di farsi trasportare chiudendo gli occhi. L’esordio discografico del musicista umbro Giulio Ronconi in arte Hey Saturday Sun (ispirazione palesemente tratta dal brano del duo elettronico Board of Canada) non è nulla di ciò che vorrei ascoltare la mattina appena sveglio, in qualsiasi tipo di viaggio (terreno) o mentre redimo la mia coscienza facendo la mia corsetta amatoriale. Però è sicuramente un prodotto raro per intensità e per il suo sound, mai banale e mai relegato ai comodi schemi dei generi musicali.
La lunga intro affidata a “Pulsewidth Noise” ci rimanda subito ad un’altra dimensione, meno carnale ma non per questo fittizia, mentre “Silent Kid” fa l’occhiolino all’elettronica viva di Moby e ci detta un passo molto soffice e lento, sappiamo però che piano piano di strada ne faremo molta. Gli echi e i vocalizzi di Marta Paccara conferiscono l’atmosfera giusta e il pianoforte rarefatto pare avere i tasti congelati e dipinge in aria immense praterie mischiate a enormi palloncini fluttuanti. La cavalcata New Age “The Other City” è una precisa descrizione di paesaggi stellati, mentre “Lullaby” finalmente azzarda anche la batteria e richiama i tanto attesi anni 80. Sorpresa! Ecco le chitarre di “1.9.8.9”, il pezzo più forte e scellerato del disco. Senza esagerare questo è il momento più Pop e ciò non ci dispiace affatto. Rullate decise e voci si scontrano, si amalgamano come nuvole in rivolta. Tutto però rimane quassù e il contatto con il suolo è un lontano ricordo. Le due metà di “Museum of Revolution” sono un vortice, un fiume in piena, una cascata di sensazioni a fior di pelle. Una carrellata di suoni che non si limita ad essere un semplice esercizio. La carica e la botta da me tanto adorate sembrano rinchiuse in una teca di vetro da cui escono solo leggeri sussurri, suoni non per questo però privi di forza: viscerali anche se visionari, ma soprattutto positivi.
Un bel sogno possiamo dire, mai troppo finto da sembrare pura immaginazione. Hey Saturday Sun è il sole calmo di una domenica di inverno, quello che non ti aspetti, che ti scalda appena appena sbucando dalla finestra, entra nelle tue coperte e si unisce alla tua dormita godereccia. Una sensazione di respiro di aria buona a pieni polmoni, lontano dalla merda quotidiana che ci tocca ingurgitare.