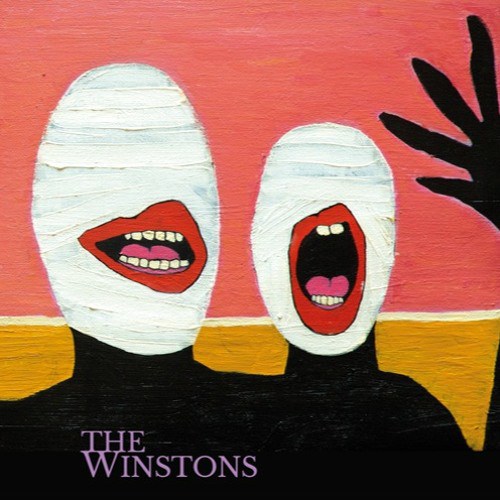Pubblicato il 27 Marzo, domenica di Pasqua, Ricordati di Santificare le Feste è il secondo lavoro dei Flowers and Paraffin, giovane band campana che due anni fa realizzò un breve Ep (5 pezzi in 12 minuti) che faceva ben sperare per questo seguito. I sei ragazzi provenienti dalle province di Salerno ed Avellino in questo nuovo lavoro, che si sviluppa in 7 pezzi che scorrono via in 19 minuti, non solo non hanno disatteso queste speranze ma sono riusciti a fare un buon passo avanti evolvendo il loro sound. Questo secondo capitolo porta infatti a maturazione la ricetta del buon esordio accompagnandola a soluzioni strumentali ora divenute più ricche soprattutto nei momenti in cui la band cerca soluzioni diverse (Post Rock, Math Rock, Shoegaze) che diventano ben più dei brevi inserti che si potevano trovare in Caduta e che suonate con la loro inclinazione Emo Post-Punk (senza dunque perdere in immediatezza) portano ad un buon guadagno in intensità. Non manca inoltre una crescita anche nelle liriche sempre basate sulla sublimazione di confusione, incertezze e paure della terra di mezzo dei ventenni nonché sull’immancabile ed altrettanto confuso argomento amore, che in questa seconda prova, nonostante qualche piccolo passaggio a vuoto, guadagnano comunque indiscutibilmente in spessore.
In quasi ogni brano della scaletta vedremo alternarsi momenti musicalmente soffusi ad altri ben più tirati ad accompagnare liriche ora espresse con uno spoken abbandonato a sé stesso ora urlate come per liberarsi da pesi troppo pesanti da portare per una sola schiena (come dichiarato nella conclusiva “Maledetta Gioventù”). Troveremo i momenti migliori nelle ben coese “Conta”, “Cosmo (Andrea)” e “Autoritratto”, brani dove l’incastro tra musica e parole risulterà pressoché perfetto, dove le chitarre ora carezzevoli ora graffianti pur facendo la parte del leone non ruberanno la scena a tutto il resto: una sezione ritmica sempre puntuale e pronta a pestare nei momenti più tirati, un synth che decora con precisione e senza risultare invasivo. In questi brani, che sono anche quelli dalle liriche più intense, troveremo gli incontri meglio riusciti tra l’innato animo Emo Punk della band e le deviazioni in altri territori di cui si parlava sopra e sarà sicuramente possibile sentirci una riuscita fusione, tra i tanti, di Marlene Kuntz, Fine Before You Came e Massimo Volume.
L’idea di terapia di gruppo tra amici segnalata dalla cartella stampa descrive bene l’intenzione dei sei ragazzi e si fa viva anche durante l’ascolto, i testi sono spesso delle confessioni, delle (ri)scoperte di sé che la band accompagna con complicità e riuscendo a creare una discreta tensione, considerando tra l’altro che stiamo parlando di ragazzi ancora giovanissimi che ad oggi in due lavori ci hanno regalato mezz’ora di quel che sono, mezz’ora di questa sofferta crescita che li porterà ad essere quel che saranno.
In estrema sintesi: promossi.