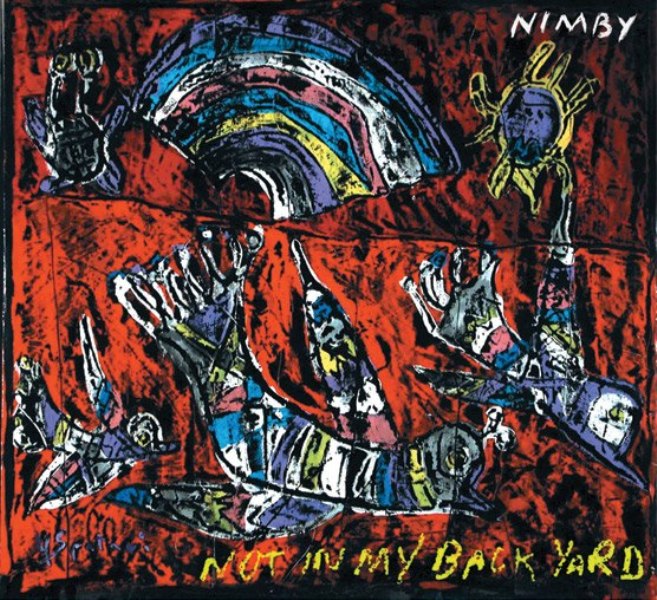È la seconda “volta” per i milanesi The Spezials, ed è un piccolo registrato da emozioni spigliate che, davanti vorreste condividere con tutti e che invece ve lo terreste tutto per voi, gelosi della loro attitudine grattugiante e diretta che sforma un ascolto imprevisto, o che può correre il rischio – tranquillo – di essere incredibilmente ostaggio di una sensibilità FM Alternative oltre i limiti; Crazy Gravity è la fissazione riuscita di suonare sia con certe spiritualità ispiratrici che con l’audacia amplificata della creatività, fuori comunque dagli ordini costituiti del piacere modaiolo a tutti i costi.
Registrate in crowdfunding su piattaforma musicraiser, le dieci tracce del disco, se ascoltate in sequenza determinante, sono una perfetta e definita sintesi di tutte le bipolarità umorali dell’ultima generazione, una scaletta che alterna la dolcezza di una ballata ventilata “Two Girls” e il cozzo del rock nudo e crudo della titletrack, un’onda calda dalla personalità multipla che stringe il microfono dell’ascolto e spiazza nella sua sincera coralità miscelata; pulito da tutte quelle banalità che si annidano come germi a presa rapida in milioni di produzioni underground, Crazy Gravity esprime davvero bella musica, quelle tonalità tutte inglesi di controbattere la noia con infinitesimali meraviglie senza demoni o altre astrusità rabbiose. Belle chitarre d’assalto dolce, una voce che compete sul ritmo sempre di corsa e quella liberazione sonora che si paragona con esuberanze Arctic Monkeys, qualcosa di sottofondo della Leeds punkettara d’antan “Futuristic Horse”, “Morning Dead”, poi tutto quello che è in più e una rivelazione spiritata da tenere stretta e puntarci sopra.
Disco “birichino” e fruibilissimo, un suono totale che mescola ironia e mood frizzante, impasta e modella come plastilina il suo argento vivo e la sua concreta effervescenza, che racconta le sue storie col fiatone “Shimbone” e con le stramberie disco – danzereccie che provano a riscrivere una stringa di tempo che fa piacere – risentirla in vocoder – tra una cosa e l’altra “Normal”.
La guida all’ascolto è come una linea schizzata di angoli elettrificati, il piacere – una volta identificata tale linea – è una scarica di adrenalina che precede lo schianto con una soluzione musicale stupendamente cool.