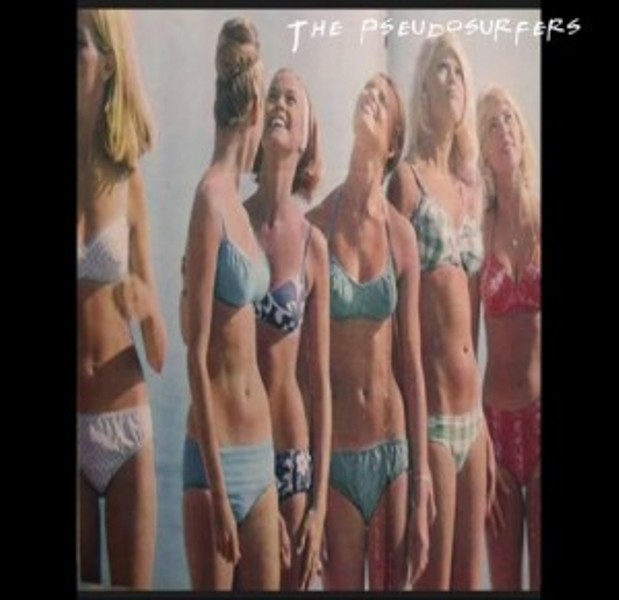Preparatevi ad ascoltare la Bibbia dei Dust. Preparatevi ad assaporare le note e le parole dei sei profeti del Rock di Milano; Andrea (voce splendida e autore di gran parte dei testi), Riccardo, Jimbo (chitarra solista dal 2009), Tomas, Gabriele e Muddy. Preparatevi a tutto. Per cogliere solo alcune delle sfaccettature del disco, servirà un notevole avvicendamento delle vostre percezioni. La giusta mescolanza di acume e beatitudine. L’Ep “Kind” è il loro secondo lavoro, dopo il demo autoprodotto del 2009 “Tuesday Evenings” e la giusta conclusione di una peregrinazione a colpi di perfette esibizioni live e l’inizio di una nuova vita. Registrato al Mono Studio di Milano e prodotto da Matteo Cantaluppi (The Record’s, Punkreas, Canadians, Bugo), che avrà un ruolo primario per lo sviluppo del sound Dust, con l’apporto di Matteo Sandri (Sananda Maitreya, Il Genio) e il mixaggio, in due brani, di Paolo Alberta (Negrita) all’Hollywood Garage di Arezzo, “Kind” si presenta tanto breve (ventuminutieventottosecondi) quanto intenso e ricco di spunti. Partiamo dall’inizio. “O my Mind” (che vede la partecipazione di Giorgio Garavaglia, mandolinista e direttore d’orchestra) ci regala subito un giro che te lo levi difficilmente dalla testa e una melodia spensierata di quelle che ti mettono la gioia di vivere.
Il timbro intenso di Andrea allarga le nostre percezioni verso orizzonti Wave in stile The National. Un brano che si lega al passato in maniera indissolubile eppure suona alle nostre orecchie carico di una fresca e inaspettata originalità. Ti entra nella testa senza squarciarla e riempie quello spazio rimasto da troppo tempo vuoto nel tuo cervello. Il mix tra chitarra, voce e linea di basso sembra un melodioso ludico correre nel buio spazio vuoto del niente. Qualche cosa sembra già chiara. I Dust hanno scelto la strada popular nel traffico del Rock. Niente fretta però. Il secondo brano, “Ink Loaded Love”, con le sue elettriche sferzate e le urla soffuse, mette già in crisi le nostre certezze. I milanesi sembrano accarezzare un certo tipo di Grunge, meno legato all’Hard Rock, se volete, ma più Pop, mantenendo tuttavia viva la loro porzione d’anima Dark Wave. In pratica un groviglio complicato gettato da una muraglia sonora in fiamme. “In Collapse of Art” potete prendere la vostra testa e scaricarla nell’indifferenziato. Rallenta il ritmo e la musica si trasforma in materia oscura come il Blues. I Dust continuano ad attingere, anche involontariamente, dal continente Nord Americano. La malinconia dei Girls sposa le atmosfere folk meno folk degli Okkerville River (l’inizio del brano vi ricorderà certamente l’inizio di “Titletrack” dei sopracitati) ma il matrimonio si trasformerà nel giro di due minuti in un pandemonio nervoso che si risolverà in parte col ritorno all’origine, un ritorno alla pacatezza solo esteriore del blues degli episodi più malinconici di Dan Auerbach. Un brano che comunica l’incapacità comunicativa attuale dell’arte in Italia. Il trionfo dell’apparire sull’essere. Con “Never Defined”, riaffiorano le atmosfere Wave scuola The National (quelli più energici di High Violet) e la chitarra stilla gocce di Lsd che finiscono dritte nel cuore. Il brano, come a riassumere l’intero Ep, si palesa senza paura nella sua totale complessità. I rimandi ai grandi nomi sono infiniti e si accavallano all’interno del singolo brano cosi come nella totalità dell’opera. Eppure tutto si fonde in una divina unicità.
L’album si chiude con la romantica “Still Hiding, Still Trying” nella quale si torna a danzare tra le nuvole come in “Collapse of Art, ma abbracciati a una donna splendida, vestita di nero, con tacchi alti e labbra carnose, chiamata Morte. La voce prende le redini del nostro ascolto con una delicatezza sublime e ci accompagna all’uscita mentre la chitarra sventola note sotto una brezza umida e la batteria pulsa come un cuore rivelatore nel profondo della nostra essenza. Il sound nella sua delicata ricercatezza, nei suoi accenni psicheledici, nella sua teatrale, passionale empatica vocalità ricorda ancora quello di Christopher Owens e delle sue “ragazze” americane ma sempre senza scimmiotteschi rimandi. Ora potrà sembrare che vi abbia detto tutto. Non è cosi. Riascoltate l’Ep e tutto sarà diverso. Come ho detto (a mezza bocca) in precedenza, la caratteristica del sound dei Dust è proprio questa. Ti sembra di aver compreso solo fino a quando non rischiacci play. Il primo impatto che ho avuto è stato quello di una band di chiara ispirazione Buffalo Tom (o che comunque per uno strano scherzo del destino, lo sembra in maniera netta). Non è tutto qui. Ferma restando la struttura cardine chitarra/voce di un prodotto comunque rivolto all’apprezzamento popolare, la miriade di mondi musicali racchiusi nel disco si accavallano a ogni ascolto. Cosi come si avvinghiano le emozioni della vita, del vagabondare nel mondo, della socialità, dell’amore e della morte. Se una volta il Rock Pop-Punk spensierato, fuso al Folk e al Power Pop da muovere il culo, in stile Lemonheads sembrerà essere la colonna portante del tutto, il giorno dopo vi sembrerà piuttosto di essere cullati dalle atmosfere più melodiose e levigate del Blues, in combutta col Soul e il Grunge, specie nella parte cantata. Oppure vi sembrerà di riascoltare il miracolo degli Arcade Fire e del loro Pop-Wave, magari solo per un attimo. Vi sembrerà di ascoltare Wilco o i R.E.M o il Jangle Pop dei The Smiths. Un attimo che vi farà pensare abbastanza da far ripartire il disco dal principio. La prima pietra è ben salda. Aspettiamo la lunga distanza; aspettiamo un album oltre l’ Ep. Allora potremo dire veramente quale sia il valore dei sei. Intanto alcune cose sembrano chiare. Ai Dust piace la musica d’oltreoceano più di quella d’oltremanica. Ai Dust piace fare Rock senza suonare mai troppo pesanti (difficili, meglio). Ma soprattutto è chiaro che questo “Kind” come la Bibbia, si è presentato come il luogo in cui cercare le risposte, ma non fa nient’altro che avvinghiarci in continue altre domande. “Dream unless you can see the truth”. Dov’è la verità?