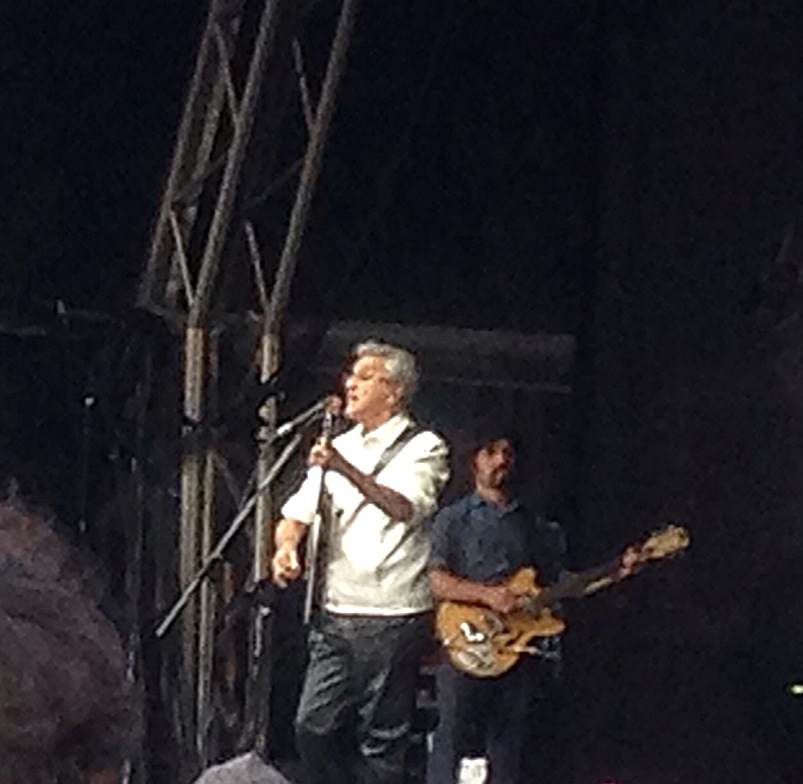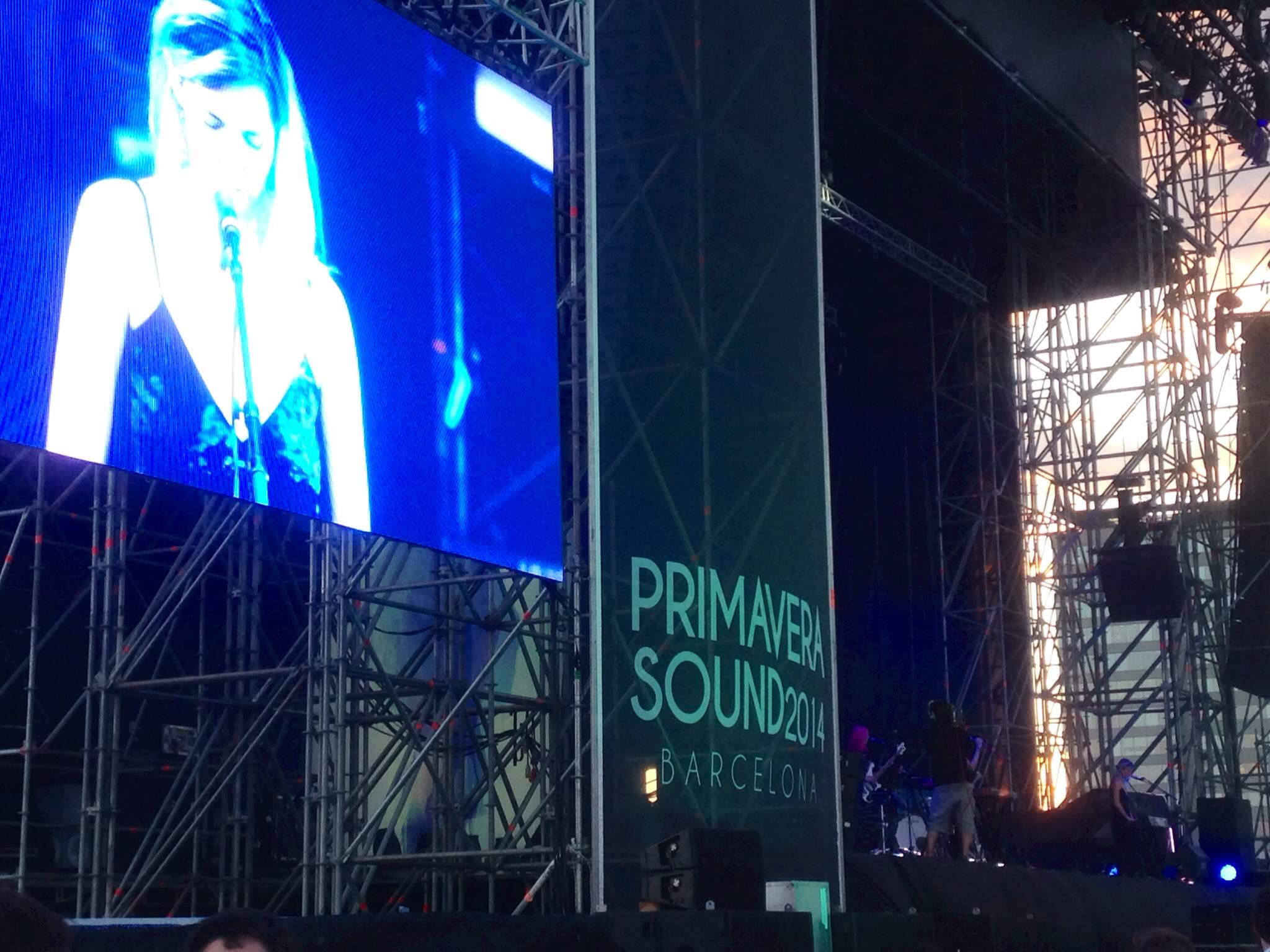(Un ripasso dei giorni precedenti? Subito accontentati Day 1 e Day 2)
Quindi, ricapitolando: niente panico, respirate a fondo, non bevete troppo perché tanto per l’occasione l’Heineken sfodera birra analcolica e ve la spaccia per normale (alla sesta 0.5 ero perfettamente sobria) e portatevi tanto cibo quanto ve ne metteva la mamma nello zaino per mandarvi in gita alle medie, altrimenti in quei tre giorni nutrirvi vi costerà più dell’abbonamento vip. Ah, e considerate la possibilità di prendervi almeno una giornata tutta per voi. Se non siete inclini a soffrire la solitudine avrete modo di seguire ogni inconfessabile istinto, che vi porterà da artisti che in principio non avevate considerato o che i vostri compagni di festival boccerebbero categoricamente. Dico addio alla mia crew sabato pomeriggio, quando dopo un quarto d’ora di performance dei Television gli altri se ne vanno in blocco dalle Dum Dum Girls. Avrò il diritto di incazzarmi se a un tratto mi bussano su una spalla ridestandomi da una specie di goduriosa trance per dirmi “oh, noi andiamo al Pitchfork, che ci sta la figa”? Dell’articolo in questione non me ne intendo, e in ogni caso niente mi porterà via da quest’atmosfera, che se chiudo gli occhi sparisce tutto il grigio, quello dell’asfalto del Forum e anche quello che con una punta di tenerezza osservo sulla testa di Tom Verlaine, e in un attimo mi ritrovo catapultata nel verde di anni su cui posso solo fantasticare, quelli dei festival a piedi nudi sull’erba e giovane New Wave tonificante nelle orecchie. Ho detto proprio tenerezza? Sì, l’ho detto. È che queste reunion, per quanto eccitanti, rischiano di risultare anche un po’ dissacranti. Ad esserne testimoni si corre il pericolo di intaccare irrimediabilmente quell’alone di mito che circonda le formazioni storiche. Forse dovreste starne alla larga se siete come me e vi assale l’ansia di fronte all’evidenza del fatto che il tempo passa anche per le cose che ci sembrano eterne.
Un artista intimista e profondo come Caetano Veloso mi sembra così fuori contesto che non posso fare a meno di andare a dare un’occhiata. Dal Sony al Raybanè una traversata infernale di un paio di chilometri in mezzo a una folla multietnica e barcollante. Arrivo sulle note di “Parabéns”, mentre Veloso accenna movenze di danze tropicali d’oltreoceano e riempie l’etere della sua personalissima reinterpretazione Pop delle sonorità della Bossa Nova. Attorno a lui, quattro tele su altrettanti cavalletti, dipinte con semplici tratti geometrici, e virtuosismi Classic Rock che si conformano alla tradizione musicale brasiliana e la rinnovano stando bene attenti a non tradirla. Nota per gli scettici che hanno letto il nome di Veloso in cartellone storcendo il naso: è l’ennesima conferma del fatto che chi stila la line up di questa rassegna non sbaglia un colpo, consentendo nella stessa giornata un assaggio di moltissimi degli infiniti sapori che la musica sa assumere. Nonostante sia gremito, il Rayban è la location più gradevole e accogliente tra i palchi del Primavera. Spezzo il ritmo serrato da festival e prendo fiato seduta sulla gradonata, assorta tra migliaia di sconosciuti che hanno il mio stesso sorriso. La maggior parte di loro non capisce una mazza delle splendide liriche in portoghese ma questo non sembra affatto ostacolare l’empatia tra loro e gli altri, quelli che ondeggiano a ritmo in modi che la natura consente solo ai popoli di sangue latino.
Torno indietro mentre gli Spoon sono ancora sul palco Heineken. Il loro Pop Rock scanzonato e versatile non mi dispiace affatto. Quale occasione migliore di questa per i texani per sfoderare un assaggio di quello che sarà il nuovo disco che uscirà quest’anno? “Rainy Days” viaggia sul ritmo sostenuto che avevano molti brani di GaGaGaGaGa, come l’accattivante “The Way We Get By”. Britt Daniel sfoggia una camicia rosso fuoco e le sue tonalità roche, riempie il palco e intrattiene la bolgia in pieno happy hour (ce l’ho anch’io una birrozza in mano, ci vorrà ancora qualche ora prima che mi accorga della truffa analcolica di cui sopra). Segno un punto a mio favore quando ritrovo i miei amici che mi confermano che saltando le Dum Dum Girls non mi sono persa nulla. A quanto pare non basta, perché non riesco a convincerli a seguirmi al Sony, dove tra poco si esibiranno i Volcano Choir. A causa della pioggia incessante di ieri, la zona centrale della prima fila è invasa da una specie di stagno. Con i miei anfibi a prova di lotta nel fango mi ci piazzo comodamente, in compagnia di tre inglesi scalze e felici che la security non si sia accorta del loro Jagermeister & orange occultato nei contenitori del deodorante. Non so se sentirmi più cretina per non averci pensato o più elevata culturalmente nel ritenere in ogni caso che vaporizzarsi dell’alcool in bocca piuttosto che sorseggiarlo sia l’equivalente dell’accontentarsi di una flebo al posto di un piatto di gnocchi. Fuckingchoosyitalians! I Volcano Choir sono la declinazione di Justin Vernon che meglio si intona ad un sabato inoltrato. Questa faccia del poliedrico artista del Wisconsin è quella che personalmente preferisco, nuova creatura sperimentale e destrutturata che mantiene il mood intimo del lavoro firmato col moniker Bon Iver ma che gli conferisce tutt’altra energia. Justin canta dall’alto di un pulpito di legno da politicante, dietro al quale nasconde vocoder e tutto ciò con cui smembra e riassembla la sua voce, in un risultato corale, scenico e ipnotico. La giustapposizione di campionamenti e chitarra classica regala struggimenti da ballad ed episodi dance con la stessa naturalezza. Un’ora di performance vola via sulle note di Repave e del precedente album e si conclude emblematicamente con “Still”, riarrangiamento di un brano contenuto nell’EP Blood Bank firmato Bon Iver, in cui Vernon aggiunge alla versione originale tutta la ricchezza di suono seminata e raccoltanel suo percorso artistico.
Sono ancora in tempo per i GodspeedYou! Black Emperor, che già da un po’ sono sul palco ATP, il che significa ripetere la traversata di prima in senso opposto e di corsa (è solo la terza delle molte altre volte che verranno). Arrivo convinta di avere ancora mezz’ora di set da gustarmi e invece i GY!BE sono già all’ultimo pezzo. Mi sono persa una roba grossa. Maxi schermi spenti, illuminazione al minimo, è un’atmosfera minimale solenne, davanti a un pubblico composto e senza smartphone in mano. Loro sono seduti in cerchio, in una session intima che ha le sembianze di un rituale piuttosto che quelle di un live, apocalittico tra percussioni dall’incedere lento e fiati dal sapore Folk. Mi ritrovo così un buco nero imprevisto nel bel mezzo del sabato sera, la prima volta negli ultimi tre giorni in cui non so che fare. Mi addentro in quell’area ben circoscritta ai piedi del pannellone solare del Forum in cui finora non ho mai messo piede, quella specie di riserva protetta per esemplari di hipster che è la zona Vice-Pitchfork. Qui i frequentatori assidui si dividono in due categorie. I primi sono quelli che boicottano per partito preso l’area Sony-Heineken, che una legge non scritta ha bollato come mainstream, e si farebbero cavare un occhio piuttosto che assistere alla consacrazione commerciale degli Arcade Fire. I secondi sono qui a cazzeggiare in attesa di qualche reflex che li immortali, perché questo è il luogo in cui la probabilità di incappare nel fotografo di street fashion di turno è più alta (se poi nell’attesa c’è un sottofondo musicale, tanto meglio). Sul palco Vice ci sono i Cloud Nothings. Un quarto d’ora di Indie Pop senza grossi salti mortali scorre via abbastanza trascurabile mentre sono in fila per fare pipì. È un breve attimo di tregua, appena uscita dal cesso chimico mi torna la febbre da festival. Ho un appuntamento importante qui all’ATP tra circa mezz’ora e farei bene a trovarmi un angolino adeguato tra una folla che già si addensa ai piedi del palco, ma con quale faccia potrei tornare a casa e confessare che per mettermi comoda ho rinunciato completamente ad assistere alla performance dei Nine Inch Nails? Tra andata e ritorno saranno altri 5 km a piedi, ma tanto oggi s’è capito che bisogna trottare quindi amen, colleziono altri dieci punti-gioventù e torno al Sony. Tra una folla già compatta mi ritaglio uno spazietto ad almeno un centinaio di metri dallo stage, ma quando Trent Reznor e soci salgono sul palco e partono i bassi il suono mi vibra nel petto come se fossi accanto alle casse. Un animale da palcoscenico oscuro e sensuale monopolizza le migliaia di occhi al suo cospetto, sovrastato da un impianto luci mastodontico. Il sound ibrido e spasmodico dei NIN dal vivo è qualcosa di cui ubriacarsi almeno una volta nella vita. La setlist è dalla mia parte. I quattro brani che ascolto prima di correre via sono un’ottima sintesi di tutto quello che sono i NIN. Reznor appare dal nulla, tra una nube di luce blu, sui ruggiti sintetici di “Me I’m Not”. Poi l’Industrial tribale di “Sanctified”, e la tiratissima “Copy of A” del nuovo Hesitation Marks. Vibro insieme alla scarica di chitarre di “The Day the World Went Away” per poi correre via di nuovo. Rovinarsi il karma così, a metà, lo so, è una merda, ma lo show che mi aspetta ora non avrà nulla da invidiare a questo in quanto a potenza, fisica ed evocativa, di quella che ti imprime ogni dettaglio nella mente e rende un’esibizione indimenticabile. È la mia prima volta coi Mogwai.I tipi in questione non li assimili finché non assisti in prima persona ad un live. Ciò che i Mogwai sono in grado di sprigionare dal vivo è qualcosa che nessun supporto fisico inciso è in grado di contenere. Sul palco, in bella vista, la bandiera della Catalogna. Luci soffuse accompagnano la pioggerella di synth di “Heard About You Last Night”, nel lento e cadenzato incedere delle percussioni. Sono già senza fiato. Non è solo una questione di volume esagerato, l’aria graffiata dalle chitarre di “I’m Jim Morrison, I’m Dead” ti scava il petto. Le note sussurrate di “Ithica27ø9” ammaliano con grazia per poi stringerti in una morsa, in un gioco che accelera e decelera per poi esplodere. Melodiose catarsi generate dal violino di Luke Sutherland mutano in barriere di suono dense che investono, tanto che ti viene da puntare bene i piedi a terra per non correre il rischio di essere spazzato via dai poderosi riff. C’è spazio anche per i primissimi Mogwai di “Mogwai Fear Satan”, groviglio di suono elettrificato ed elettrizzante. L’oscura “Deesh Rave” è viscosa ed enfatica con Sutherland alle percussioni, di spalle, con la solennità di un rito tribale. “Remurdered” è una bomba sintetica, su quella linea che lega tutto Rave Tapes, il synth che a un tratto parte in loop è gia inconfondibile. Con poche parole i Mogwai ringraziano il pubblico e il Primavera per la gentile concessione di poter suonare in presenza dei GY!BE. Poi chiudono con “We’re No Here”, terrificante nell’incedere del suono che si tramuta in totale delirante distorsione che dura svariati minuti e ci lascia storditi ed estasiati.
Ancora un grazie al Primavera che bilancia set epici con rigeneranti performance di decompressione. Dopo aver saltato tutti gli altri appuntamenti coi connazionali presenti alla rassegna, mi concedo una sosta all’Adidas per un paio di brani dei Junkfood, che dopo la turbolenza che mi ha appena investita sono esattamente quello di cui ho bisogno. È un piccolo stage accogliente di fronte al mare, sul quale il quartetto italiano espone tutta la propria ardimentosa impresa compositiva, un Alt Jazz destrutturato che è uno dei frutti migliori del panorama nostrano degli ultimi due anni. Big Jeff sembra essere d’accordo con me, accennando col suo testolone riccio un headbanging da metallaro improprio quanto coinvolgente (Big Jeff chi?). Recupero i miei amici al set dei Foals all’Heineken, dove il pubblico sembra avere ancora tutte le forze per scatenarsi su questo raffinato Math Rock mentre io sono ormai all’ultimo stadio delle mie capacità motorie. L’ultima traversata del recinto del Forum è verso l’uscita. Di passaggio di nuovo all’ATP, l’Indietronica dei Cut Copy non riesce a convincerci a restare oltre un paio di pezzi.
È stata una gran bella storia. ¡Adiós, Barcelona, hasta el próximo año!